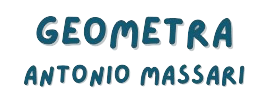Le planimetrie catastali sono un documento essenziale per la rappresentazione di un bene immobiliare, fornendo tutte le indicazioni circa il perimetro e la suddivisione interna.
Essendo rappresentazioni in scala, consentono di misurare la grandezza dei diversi vani e calcolare conseguentemente le tasse.
Ci sono voluti diversi secoli per arrivare all’accuratezza della rappresentazione attuale e alla tecnologia del catasto attuale, ma nel corso del tempo queste pratiche hanno largamente influenzato la gestione del territorio italiano, prima selvaggia e priva di controllo, poi sempre più capillare grazie alla realizzazione di registri e sistemi di censimento delle proprietà.
Ripercorriamo pertanto la storia e l’evoluzione delle planimetria catastali in Italia, osservando una loro nascita, seppure parziale, con i primi registri fondiari, fino ad arrivare al sistema digitale della rasterizzazione utilizzato nei tempi moderni.
Dalle origini al medioevo
Bisogna spingersi parecchio indietro nel tempo per giungere all’origine di una forma rudimentale di planimetria catastale, in quanto in Italia fu la dominazione araba ad introdurre una sorta di registri detti Defetari.
Ci troviamo nel X secolo, quando per la prima volta si avverte l’esigenza di realizzare un primario catasto, con la difficoltà di raccogliere le proprietà di cittadini dislocati sul territorio, alcuni difficili da raggiungere e isolati dagli insediamenti più grandi.
Un primo perfezionamento di tale sistema venne apportato dai normanni, che elaborarono un più accurato registro chiamato Catalogus Baronum, cioè Catalogo dei Baroni.
Di fatto, questo censiva i possedimenti dei vassalli del territorio controllato dai Normanni, che avevano terre, latifondi, palazzi e castelli, in buona parte riportati all’interno dei documenti ufficiali, insieme a una rappresentazione grafica, seppure piuttosto rudimentale.
Da questa modalità erano però esclusi i normali cittadini e possessori di beni e pertanto ancora non era possibile avere un’idea organica e precisa dei possedimenti all’interno dei regni.
Il medioevo fu un secolo di evoluzione da questo punto di vista, grazie all’introduzione degli estimi dei registri comunali che raccoglievano beni immobili e mobili di ogni persona, con relativa rappresentazione grafica.
Rendere particolare la raccolta fu una notevole intuizione, in quanto era molto più semplice procedere sul singolo comune, ognuno per proprio conto, piuttosto che a livello globale e su territori spesso ampi e dislocati.
L’avvento di Napoleone e la formazione del Regno d’Italia: cosa cambia nei registri e nella realizzazione di rudimentali planimetrie
L’avvento di Napoleone apportò innovazione sotto vari punti di vista, compenso quello della creazione di un sistema sempre più simile al catasto attuale.
Se prima il sistema era molto frammentato e ogni realtà procedeva in modo autonomo e diverso dalle altre, la sua prospettiva fu decisamente più unitaria, introducendo una procedura univoca e obbligatoria.
Le planimetrie del periodo iniziano ad essere più accurate, anche se ancora non è possibile parlare di scala e quindi della possibilità di misurare un bene tramite il documento cartaceo.
Molti documenti sono poi andati persi a causa dei moti e degli incidenti del periodo, ma abbiamo comunque una discreta mole di testimonianze che mostrano il progresso del sistema catastale, sempre meno embrionale.
Veniamo quindi a uno dei momenti più importanti della storia moderna del nostro Paese, quello dell’unificazione, che ha dato finalmente un’identità unitaria alla Nazione e ha apportato una serie di cambiamenti importanti, limitando il potere delle realtà particolari.
Ad essere revisionato fu proprio il catasto, con la raccolta dei dati e la rappresentazione delle planimetrie.
Alcuni registri, infatti, utilizzavano criteri geometrici, altri solo descrittivi e matematici, creando una grande confusione nel caso in cui andassero confrontati fra loro.
Il fatto che si utilizzassero scale e misurazioni molto diverse fra loro comportò un primo fallimento dopo la formulazione della legge sul conguaglio provvisorio, che prevedeva il pagamento di tributi in base alla superficie dell’immobile posseduto.
La vera svolta avvenne quindi con la cosiddetta legge Messedaglia, regolata dal decreto del 1º marzo 1886 n. 3682, che prevedeva la realizzazione di un unico catasto per il calcolo delle imposte e soprattutto una rappresentazione cartografica unitaria, secondo il sistema di Cassini e Soldner.
Passare dalla teoria alla pratica non fu affatto facile, in quanto diverse realtà, soprattutto le più dislocate, non volevano abbandonare il vecchio sistema tavolare o terenziano.
Basti pensare che questo è ancora oggi attuato in alcune province che non si sono mai volute uniformare, come quella di Belluno, Trieste, Trento e Bolzano.
Lo scopo era dare una valenza probatoria al catasto, ma la difficoltà di uniformare i documenti allo stato di fatto era davvero elevata e questa funzione fu esclusa, seppure in termini di ordine e uniformità i risultati furono presenti.
Dal 1900 a oggi, come cambia il catasto e la rappresentazione grafica degli immobili
La storia contemporanea prevede una tappa importante per quanto concerne il censimento dei beni e la loro rappresentazione, con la creazione della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici nel 1901.
All’interno di questa legge, precisamente al n. 321/1901, venne inoltre introdotto il concetto di frazionamento, che necessiterà però di diversi anni per essere regolato come accade attualmente.
Grazie al R.D. 8 dicembre 1938, n. 2153, venne poi finalmente inserita una distinzione importante tra catasto terreni e catasto catasto urbano, essenziale dal punto di vista della tassazione per un calcolo corretto del bene.
Di appena un anno dopo è infatti la creazione del catasto fabbricati dell’11 settembre 1939, mantenuto in vigore fino al 1962.
Nei 30 anni successivi furono introdotte diverse novità, come il concetto di mappale nel 1969, fino alla gestione attuale del Catasto da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La planimetria catastale rasterizzata: cosa significa?
Attualmente si parla di planimetrie catastali rasterizzate, rappresentate con un contorno geometrico attorno al documento.
La presenza di tale perimetro quadrato indica che il documento è stato depositato digitalmente al catasto ed è presente all’interno degli archivi, per una consultazione in ogni momento e senza dover per forza reperire la versione cartacea.
Si tratta di un sistema avanzato di raccolta delle planimetrie degli immobili, più facili da ottenere e sottoposte a un controllo più accurato per verificarne la corrispondenza allo stato di fatto.
Le planimetrie catastali moderne, oltre che la rappresentazione in scala dell’immobile, solitamente 1:200, recano anche l’indirizzo e i dati catastali dello stesso, come una sorta di carta d’identità del bene.
Si tratta di documenti essenziali da allegare in sede di compravendita all’atto, verificando che ci sia rispondenza e facendo eseguire, da un tecnico abilitato, un eventuale allineamento allo stato di fatto se risultato delle difformità.
Nel corso dei secoli le planimetrie catastali sono decisamente cambiate, ma durante la loro evoluzione hanno contribuito a gestire meglio il territorio italiano dal punto di vista dei possedimenti e dei contributi da pagare, anche se per molti anni la gestione è stata di tipo particolare e non univoco, come avvenuto dopo l’Unità d’Italia e il suo consolidamento dal punto di vista normativo ed istituzionale.